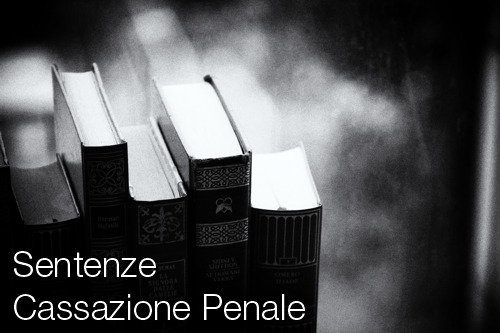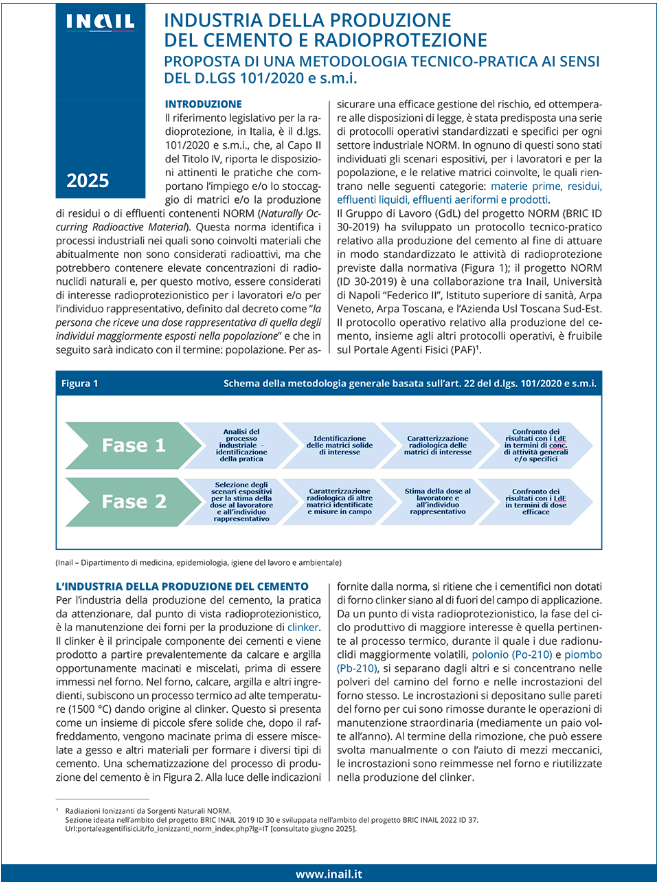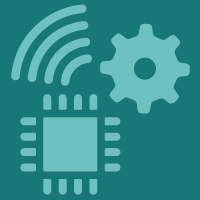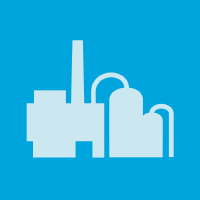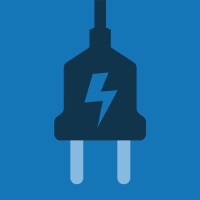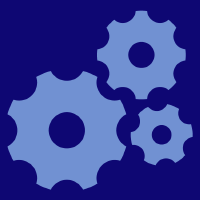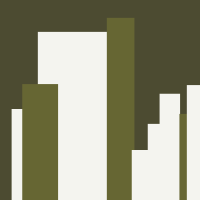Considerato in diritto
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Con riguardo alla esatta ricostruzione del percorso causale che ha condotto all'infortunio, la difesa sembra dubitare del fatto che la perdita di equilibrio sia elemento idoneo e sufficiente ad esprimere il giudizio esplicativo circa la causa dell'infortunio. Il giudice di primo grado aveva già ritenuto che la scala messa a disposizione del lavoratore fosse inidonea a prevenire il rischio di caduta, sia a causa del cattivo stato d'uso dei dispositivi antisdrucciolevoli, sia a causa dell'assenza di presidi anticaduta quali la piattaforma e il guardacorpo. Nella sentenza di appello risulta, ulteriormente, chiarito per quale ragione il fatto generatore della perdita di equilibrio fosse da considerare non dirimente nella prospettiva del rischio al quale è esposto il lavoratore in caso di lavori in quota. Si tratta, evidentemente, del rischio di caduta da altezze tali da comportare l'eventualità di lesioni o decesso. Letta da questa posizione prospettica, la motivazione è esente da vizi, avendo puntato l'attenzione, con logica ineccepibile, sulla regola cautelare idonea ad evitare il rischio di caduta e, a monte, sull'antecedente causale di una caduta involontaria, ossia sulla perdita di equilibrio. In tal senso, l'asserita mancanza di certezza processuale circa l'esatta dinamica dell'infortunio ha trovato puntuale e coerente replica nel provvedimento impugnato.
1.2. Ma anche sotto il profilo della dedotta abnormità del comportamento del lavoratore, giova ricordare che il datore di lavoro può invocare tale causa di esclusione del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento ove abbia tenuto un comportamento pienamente rispettoso della normativa antinfortunistica. Nel caso concreto, l'inidoneità delle misure antinfortunistiche, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è stata desunta dal concreto aggiramento di esse da parte del lavoratore, né la condotta del lavoratore era idonea, per le regole cautelari che i giudici di merito hanno ritenuto essere state violate dal datore, a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere da quest'ultimo. La difesa ha omesso di confrontarsi con le specifiche violazioni richiamate nella sentenza in relazione alla scelta della scala a pioli e alla conformazione di essa; nè mostra di aver considerato che a pag.8 della sentenza è presente specifica replica alla censura inerente alla esperienza e formazione del lavoratore.
1.3. Va richiamato, in proposito, l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità, a mente del quale non può configurarsi un rischio «eccentrico», concretato dall'imprudenza del lavoratore e idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l'omissione del datore di lavoro e l'infortunio, in caso di assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
2.1. La critica mossa alla qualificazione del fatto come lavoro in quota trascura, parcellizzandola, la motivazione complessivamente offerta nella sentenza, ove si è, in primo luogo, richiamato il profilo di colpa specifica indicato nel capo di imputazione a proposito del fatto che la scala fornita fosse priva di piattaforma e di dispositivo guardacorpo per poi sottolineare come, nel caso concreto, il lavoratore si fosse trovato a operare senza tali dispositivi sull'ultimo gradino della scala, che secondo quanto indicato nel capo d'imputazione non aveva interamente sfilato, così ancora una volta rimarcando come la caduta avesse concretizzato il rischio che le regole cautelari previste per quella lavorazione tendevano a prevenire. La presenza di piattaforma e di guardacorpo ha, infatti, la funzione di porre il lavoratore in una posizione stabile e di fornirgli un appiglio in caso di sbilanciamento.
2.2. Va qui ricordato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione anche qualora le sentenze dei due gradi di merito siano conformi, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez.4, n.35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 5, n.48050 del 2/07/2019, S., Rv. 277758). Ma è anche necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento nell'economia della motivazione (Sez.6, n.36512 del 16/10/2020, Villari, Rv.280117). Tale decisività risulta del tutto obliterata. E, d'altro canto, le circostanze inerenti ai presupposti fattuali utili alla qualificazione dei compiti svolti dal lavoratore deceduto come lavori in quota non assumono, per quanto detto, nell'economia della decisione, quel carattere dirimente necessario per potersi configurare il vizio dedotto.
2.3. La circostanza che la scala fornita alla vittima fosse allungabile era già indicata nel capo d'imputazione, ove si era ricondotto anche all'omessa formazione del lavoratore lo scorretto posizionamento dell'attrezzo; i giudici di merito hanno attribuito rilievo dirimente, in logica correlazione con il fatto accertato, all'altezza della scala resasi necessaria agli occhi del lavoratore per l'esecuzione del lavoro commissionato, ponendo in evidenza che per l'affissione del cartellone pubblicitario il lavoratore aveva avuto la necessità di sistemarsi a cavallo dei due tronchi della scala, tanto da tentare di scavalcare la sommità della stessa.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale limita la pretesa, nell'ambito dei più ampi rimedi riconosciuti al danneggiato dal diritto civile, al risarcimento e alle restituzioni previsti dall'art.185 cod.pen., dunque in stretta e immediata correlazione con il danno criminale; oltre il suddetto limite, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale comporta anche talune alterazioni derivanti dal fatto che l'accertamento del danno civile deve essere condotto secondo le regole del processo penale e che l'azione penale non può subire rallentamenti a causa dell'esercizio delle azioni extrapenali. In particolare, l'incondizionata possibilità per il giudice penale di affermare che le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno riverbera con evidenza i suoi effetti sull'onere di allegazione e di prova spettante alla parte civile, che può scegliere, senza incorrere in alcuna nullità, a differenza di quanto avviene nel processo civile (Sez. 3 civile, n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 61821001), di allegare genericamente di aver subito un danno (Sez. 6, n. 7128 del 22/12/2015, dep. 2016, Biffi, Rv. 266537; Sez. 6, n. 27500 del 15/04/2009, Morrone, Rv. 244526; Sez. 4, n. 13195 del 30/11/2004, dep.2005, Dorgnak, Rv. 231212). Il legislatore ha, dunque, strutturato un sistema «aperto» dell'azione civile nel processo penale, consentendo all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno e in rapporto alle diverse tipologie di reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entità del danno, che sarà liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia di condanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatoria, più strettamente legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificità della domanda.
3.2. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si rinviene la massima per cui sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini c[vili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire (Sez. 5, n. 25597 del 14/05/2019, Galassi, Rv. 277311; Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, Giacalone, Rv. 254672). Ma tale principio interpretativo deriva la sua ragion d'essere dt11 fatto che la parte lesa trova titolo al risarcimento del danno nel reato quale «fatto illecito» e non già nel reato quale modello legale, per cui occorre che dalla diversa qualificazione giuridica del fatto come illecito penale possano derivare conseguenze modificative del diritto della parte civile al risarcimento del danno.
3.3. Con specifico riferimento alla formulazione della causa petendi e del petitum, peraltro, la modifica dell'imputazione mediante introduzione di un diverso profilo di colpa non impone una specifica modifica delle conclusioni, pur sempre riferibili alla medesima causa petendi del reato contestato e al medesimo petitum, inerente alla più ampia richiesta risarcitoria genericamente formulata che, indipendentemente dal nomen attribuito al fatto illecito, ricomprende tanto i danni suscettibili di apprezzamento economico quanto i danni liquidabili in via equitativa in . quanto non direttamente monetizzabili· (Sez.4, n.6380 del 20/01/2017, Regispani, Rv. 269132).
3.4. Non sussiste, pertanto, nel caso in esame, l'interesse della ricorrente all'annullamento del punto della decisione concernente gli effetti civili perchè si verte in tema di modifica dell'imputazione inidonea a determinare, in quanto tale, un danno oggettivamente diverso alla persona offesa (Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436), anche in considerazione del fatto che, a norma dell'art.651 cod.proc.pen., la pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile limita il giudice civile esclusivamente con riferimento al «titolo della responsabilità» affermato nella sentenza penale (Sez.3 civile n.5660 del 14/11/2017; Sez.3 civile n.18352 del 27/08/2014).
4. Essendo il ricorso infondato, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.